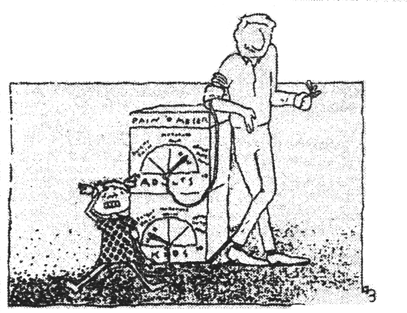
da ADVANCES in PAIN RESEARCH and THERAPY
Volume 15
Pediatric Pain 1990
Editors: Donald C. Tyler - Eliot Krane
MAUREEN POMIETTO
Gli interventi infermieristici:
uno scambio di idee
Raven Press
Traduzione del Dott. Gabriele Noferi
Gli interventi infermieristici:
uno scambio di idee
Scopo di questo scambio di idee é fare il punto sullo stato attuale delle conoscenze circa il dolore nei bambini e suggerire indirizzi per la ricerca futura. Dopo una rassegna di alcuni problemi nella definizione del dolore, farò delle osservazioni sulla sua valutazione ed esaminerò alcuni settori in cui le nostre cognizioni sono insufficienti. Infine, si affronteranno alcuni temi relativi al trattamento del dolore nei bambini.
Storicamente, definire il dolore é stato difficile sia in campo pediatrico che in medicina degli adulti. Una delle maggiori conquiste dell’Associazione internazionale per lo studio del dolore é stata la messa a punto di una definizione standard: "Il dolore é una spiacevole esperienza sensoriale ed emotiva, associata a danno effettivo o potenziale dei tessuti" 1
L’elemento del danno dei tessuti, effettivo o potenziale, é importantissimo da tenere a mente quando si tratta il dolore in un contesto tale da rendere difficile la valutazione (p.es. un bambino in ventilazione meccanica, trattato con agenti che bloccano l’attività neuromuscolare). E’ vero che in questi casi ai bambini si somministrano spesso oppioidi e ansiolitici, ma non é chiaro se abbiano o meno bisogno di altri analgesici durante procedure di per sé dolorose.
La definizione del dolore esige inoltre che la percezione soggettiva del bambino sia parte integrante della valutazione. Questo concetto é in linea con l’enunciazione proposta da Meinhart e McCaffery, secondo cui il dolore é ne più ne meno di ciò che dichiara la persona interessata 2
L’infermiera deve quindi ascoltare il bambino e capire che cosa dice, al fine di creare quella che Ross e Ross 3 chiamano "ottica centrata sul bambino", in sede di cure e di ricerca.
Molte lacune della conoscenza esistono ancora, e di questo un buon numero si riflette in quei comuni fraintendimenti del dolore pediatrico che ancora oggi sentiamo spesso enunciare. Per lo più si manifestano nell’errata concezione che i bambini provino meno dolore degli adulti o non lo avvertano affatto.
Studi in cui si é confrontato il trattamento del dolore in bambini e adulti sottoposti alle stesse operazioni indicano che queste concezioni sbagliate influiscono sugli interventi clinici: risulta infatti che agli adulti venivano prescritti e somministrati più analgesici che ai bambini.
Un altro indizio di informazione carente emerge da un sondaggio condotto all’ospedale pediatrico di Seattle, ispirato al lavoro di Bradshaw e Zeanah 4 . Meno del 50% delle infermiere segnalava esplicitamente preoccupazioni o riserve circa la somministrazione di farmaci antidolore ai bambini; ma il 73% riferiva di situazioni in cui il bambino sembrava ricevere dosaggi inadeguati, per lo più per difetto.
Meno del 50% delle infermiere interrogate in questa ricerca aveva ricevuto, nel corso della formazione e aggiornamento professionale, una panoramica adeguata sul dolore, compresi gli aspetti fisiologici, le sue manifestazioni acute e croniche e i fattori che possono influenzare l’espressione. Non erano state neppure istruite sulle tecniche, farmacologiche e di altro genere, per alleviare il dolore. Entrambi gli aspetti sono fondamentali se si vuole che l’infermiera possa farsi portavoce delle esigenze dei pazienti per un efficace trattamento del dolore.
Queste ricerche indicano la necessità di un sistematico aggiornamento professionale. Quali sono le iniziative più efficaci che ospedali e università possono intraprendere per correggere queste concezioni errate e colmare le lacune a livello d’informazione di base ?
Un programma di aggiornamento del personale può essere istituito in ambiente ospedaliero (cfr. O’Brien S., Konsler G.W., Managing children’s post-operative pain: an educational program for nurses’, Conference on Key Aspects of Comfort Managment of Pain, Fatique and Nausea, Chapel Hill (North Carolina), marzo 1988.
Corsi sul dolore pediatrico devono essere introdotti nei programmi delle scuole per infermieri e dei primi anni di medicina. Possono essere di aiuto le iniziative per lo sviluppo e qualificazione del personale ospedaliero, così come la creazione di nuove figure professionali, come l’infermiera pediatrica specializzata nella clinica del dolore.
I BAMBINI SENTONO MENO
DOLORE DEGLI ADULTI
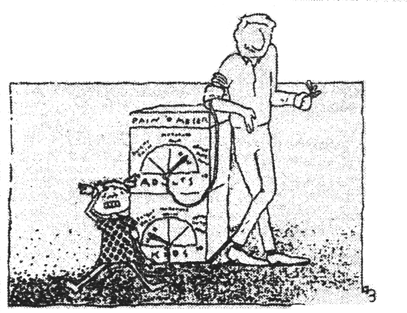
Ricorda
I bambini di tutte le età avvertono il dolore.
Il loro livello di sviluppo e l’incapacità
di verbalizzare possono impedire
l’espressione del dolore.
Fig. 1 - Questo poster sfata il pregiudizio che i bambini provino meno dolore degli adulti.
Se esiste un servizio strutturato di terapia del dolore, i membri dell’équipe possono svolgere in ambiente ospedaliero un lavoro di aggiornamento sul dolore pediatrico. Fra i modi più innovativi di promuovere l’informazione del personale, ricordiamo l’avvio in tutti i reparti di un programma che punti a favorire il comfort dei pazienti, o l’uso di poster che illustrino i più comuni pregiudizi sul dolore (cfr.fig.1).
Un settore in cui si concentra un crescente interesse scientifico é il problema della valutazione del dolore nei bambini. I progressi in questo campo hanno permesso di chiarire l’errata concezione secondo cui i bambini non proverebbero dolore o lo avvertirebbero meno degli adulti.
Nella prima infanzia, fra le tecniche tentate per una valutazione obiettiva del dolore ci sono quelle che tengono conto del pianto, dei movimenti, delle espressioni facciali e di alterazioni fisiologiche (p.es. ritmo cardiaco e variazioni neuroendocrine), ma finora la valutazione rimane di ordine qualitativo e non quantitativo.
Nel secondo anno di vita la maggior parte dei lavori, come quelli che hanno portato a mettere a punto la scala del dolore di McGrath e Coll. 5 ed altre scale di tipo comportamentale, prendono in esame il comportamento e le espressioni verbali.
Per l’età prescolastica sono disponibili scale di valutazione soggettiva a intervalli, come il "termometro del dolore" (cfr. Molsberry D.M., Young children’s subjective quantification of pain following surgery, tesi inedita, Des Miones, University of Iowa, 1979), il metodo dei gettoni da poker 6 e lo "Oucher" di Beyer 7.
Fra le tecniche usate con bambini in età scolastica ricordiamo la Visual Analog Scale, il profilo schematico del corpo, tecniche proiettive come il disegno e la scala dei colori 3. Savedra e Coll. 8 hanno concentrato l’attenzione sui termini descrittivi verbali che forniscono un’informazione circa la percezione soggettiva del dolore in termini qualitativi.
Gli schemi strutturali di colloquio come il Pediatric Pain Questionnaire 9 e The Children’s Compehensive Pain Questionnaire (cfr. McGrath P.A., The Children’s Compehensive Pain Questionnaire manoscritto inedito, London (Ontario), University of Western Ontario, 1986), permettono di ottenere dati aggiuntivi per integrare le descrizioni del dolore cronico.
E’ importante una comprensione olistica della situazione in cui si presenta il dolore, che si può ottenere attraverso una valutazione multidimensionale come quella illustrata da Stevens e Coll. 10 nella loro concettualizzazione dell’esperienza dolorifica del bambino.
Un esempio di questo tipo d’impostazione si ritrova nel lavoro di Beales e Coll.11, che notano come il significato del dolore sia correlato all’intensità delle sensazioni ed alla vivacità emotiva della risposta. Uno studio di Thompson e Varni 12 indica che a un’accresciuta coesione familiare corrisponde una ridotta manifestazione di comportamenti che esprimono il dolore. C’é bisogno di molto più lavoro di ricerca in questo campo.
Specificatamente, sono necessari altri studi empirici su tempi come la variabilità culturale nella risposta al dolore, che analizzino in particolare i fattori che predispongono al dolore (p.es., il ruolo dell’autostima, del temperamento, dell’ambiente familiare e della percezione di competenza personale). I dati della ricerca possono portare maggiore chiarezza e servire ad individualizzare gli interventi.
Il trattamento del dolore é stato trascurato in passato, ma comincia oggi a richiamare un’attenzione crescente. Ci sono studi che hanno preso in esame i vari tipi di dolore, come il dolore acuto provocato da procedure mediche (soprattutto legate al trattamento del cancro), il dolore del cancro e il dolore cronico (cefalee, dolori addominali, artrite, ecc.).
Altri campi, come le crisi dolorose per riflessi del simpatico nella distrofia e dell’anemia mediterranea, sono oggetto d’interesse crescente da parte di ricercatori. Molti scarsi sono gli studi sull’efficacia di tecniche fisiologiche e farmacologiche, come l’uso di oppioidi o di anestetici locali, o l’uso di altre tecniche per alleviare il dolore, come l’agopuntura, l’agopressione e la pranoterapia, tutti metodi che hanno bisogno di ricerche per accertarne l’efficacia.
Quanto alla valutazione, continua ad esserci l’esigenza di perfezionare le tecniche, ma ancora maggiore é l’esigenza di studi originali. Forse gruppi di lavoro raccolti per aree geografiche potrebbero sviluppare programmi di ricerca in collaborazione tale da stimolare veri passi avanti in alcuni di questi settori impegnativi.
Quanto agli interventi farmacologici, ne é stata accertata la particolare importanza nel dolore acuto e in alcuni casi di dolore cronico da metastasi. In alcuni di questi studi si é presa in esame la farmacocinetica della somministrazione di narcotici, mentre altri si sono concentrati sull’uso di nuove metodologie di somministrazione, radicalmente innovative e impostate in un’ottica evolutiva, come la regolazione autonoma dei dosaggi da parte del paziente.
Fra le altre tecniche di trattamento che abbiamo a disposizione ci sono molti metodi comportamentali e cognitivi, coma la distrazione, le immagini mentali, il rilassamento, l’ipnosi e il biofeedback. Tutte queste tecniche promuovono il controllo personale del dolore consentendo quindi ai bambini di padroneggiare in qualche misura la propria esperienza.
Mentre sono state usate per certi dolori cronici (p.es. cefalee) e per il dolore acuto provocato da procedure ripetute spesso (p.es. trapianti del midollo e punture lombari), minima é la ricerca sull’applicazione di queste tecniche al dolore postoperatorio. In linea teorica, l’ideale sarebbe insegnare ai pazienti prima dell’intervento chirurgico, in modo che potessero utilizzarle in seguito nel quadro del piano globale di trattamento del dolore.
Un unico studio (Arnestein P. e Bennet P., "Patterns and relief of discompforts following ureteral reimplant surgery", Conference on key Aspects of Comfort Managment of Pain, Fatique and Nausea Chapel Hill, North Carolina, marzo 1988) ha esaminato gli effetti della tecnica di rilassamento in bambini sottoposti ad intervento per il rimpianto bilaterale degli ureteri.
E’ risultato che una combinazione di narcotici, antispasmodici e rilassamento era la più efficace in assoluto, in particolare più efficace del solito trattamento farmacologico (narcotici più antispasmodici).
Quando si parla di trattamento, é chiaro che i problemi di organizzazione sono importanti. Il dolore dev’essere considerato un fattore prioritario.
Gli operatori responsabili del trattamento del dolore devono essere attivamente coinvolti nella cura dei pazienti ospedalizzati. Le amministrazioni che presiedono ai servizi infermieristici devono riconoscere l’esigenza di creare nuove figure, come quella di infermiera pediatrica specializzata nella clinica del dolore.
Queste figure possono svolgere un’azione di sensibilizzazione e aggiornamento e operare all’interno dell’ospedale come consulenti, ricercatori e agenti di cambiamento, oltre a partecipare alla messa a punto dei servizi multidisciplinari per la terapia del dolore nell’ambito dei reparti e ospedali pediatrici.
Riassumendo, dalla rassegna dei problemi attuali in campo clinico emergono tre considerazioni generali:
1. Come preparare nel modo migliore gli operatori della salute.
2. L’esigenza di approfondire gli studi e di sviluppare nuovi campi di ricerca.
3. La necessità di mettere a punto modi nuovi e creativi per integrare le conoscenze nella pratica clinica.
Affrontando questi temi possiamo aiutare il bambino, che é il centro focale delle nostre cure, a giovarsi di un approccio individualizzato che gli permetta di ricevere tutti gli interventi tecnici utili ad eliminare il dolore.
BIBLIOGRAFIA
1. Merskey H., "Pain terms: a list with definitions and notes on usage" Pain 1979; 6:249-252
2. Meinhart N.T., MCCaffery M. 2pain: nursing approach to assesment and analysis" Norwalk, CT: Appleton Cnetury-Crofts, 1983
3. Ross D.M., Ross S.A. "Childhood pain: current issues, research and managment "Baltimore: Urban & Schwarzenberg, 1988
4. Bradshaw C., Zeanah P.D. "Pediatric nurses’ assessment of pain in children" J. Pediatr. Nurs. 1986, 1:314-322
5. MC GrathP.J., Johnson G., Goodman J.T., Schillinger J., Dunn J., Chapman J.A., CHEOPS "A behavioral scale for rating postoperative ain in children "In Field HL, Dubner R., Cervero F. eds. Advances in pain research and therapy, vol.9 NEwYork: Raven Press 1985; 395-402
6. Hester N.O. "The preoperational child’s reaction to immunization "Nurs. Res. 1979; 28:250-255
7. Beyer J.E. "The Oucher: a user’s manual and technical report "Evanston, IL:Judson, 1984
8. Savreda M., GibbonsP., Tesler M., Ward J., Wegner C., "How do children describe pain ? A tentative assessment" Pain 1982; 14:95-104
9. Varni J.W., Thompson K.L., Hanson V., "The Varni-Thompson pediatric pain questionnaire: chronic musculoskeletal pain in juvenile rheumatoid arthrits" Pain, 1987, 28:27-38
10. Stevens B., Hunsberger M., Browne G. "Pain in children: theoretical research and pratice dilemmas" J. Pediatr. Nurs. 1987; 2:154-166
11. Beales J/G/, Holt P.J., Keen J.H., Mellor V.P. "Children with juvenile chronic arthrits: their beliefs about theil illness and therapy" Ann. Rheum. Dis. 1983; 42:481-486.
12. Thompson K.L., Varni J.W. "A developmental cognitive-behavioral approach to pediatric pain assessment" Pain 1986, 25:283-296.